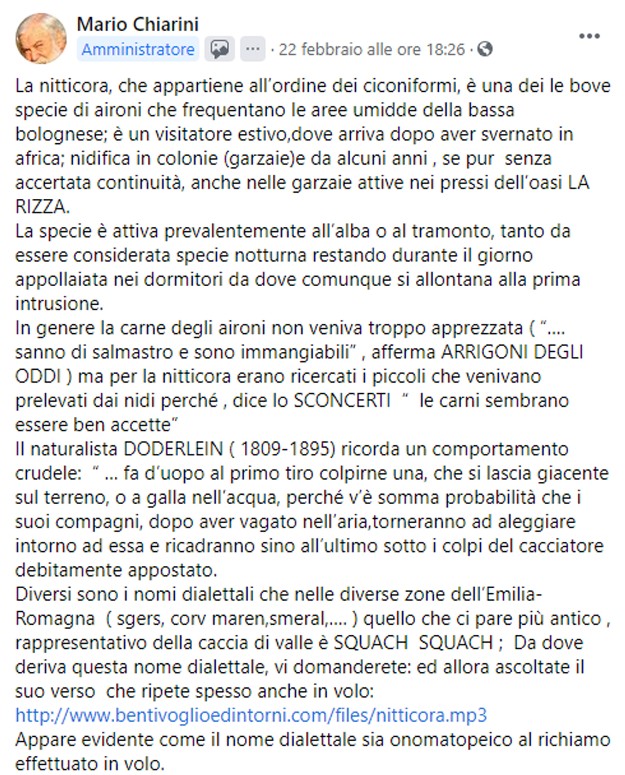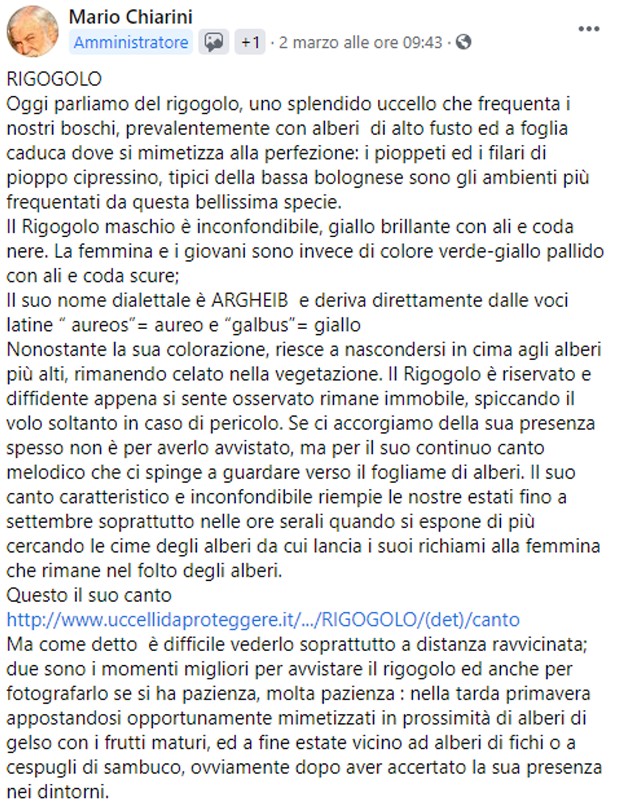Etimologia nomi da facebook pag3 - Bentivoglio e dintorni
Menu principale:
Etimologia dialettale dei nomi degli uccelli della Pianura Bolognese
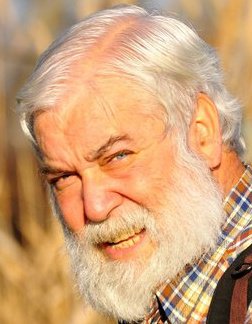
I RACCONTI DI MARIO
SU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PICCHIO MURATORE
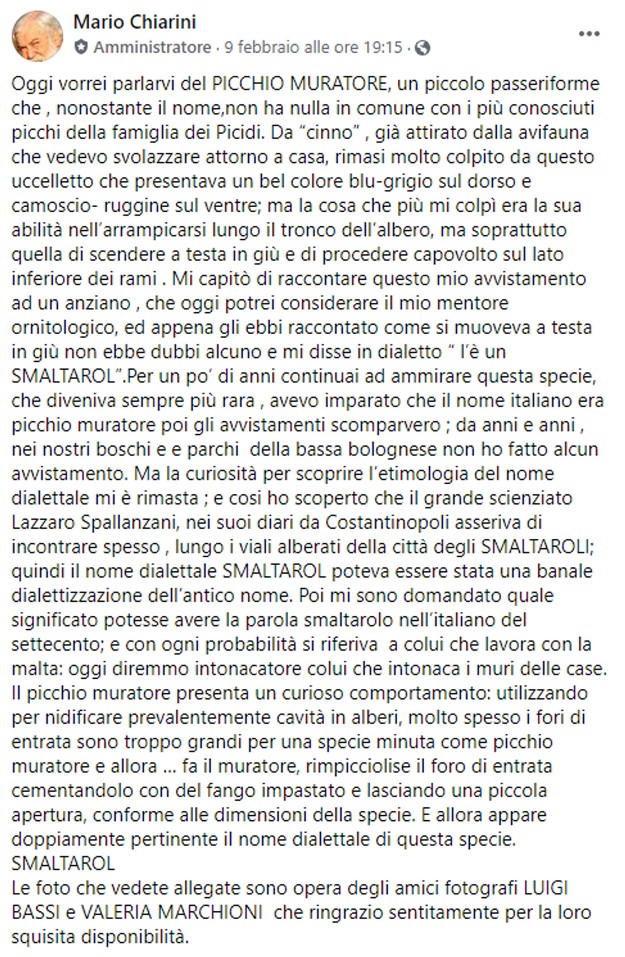




Ascolta il verso

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GARZETTA
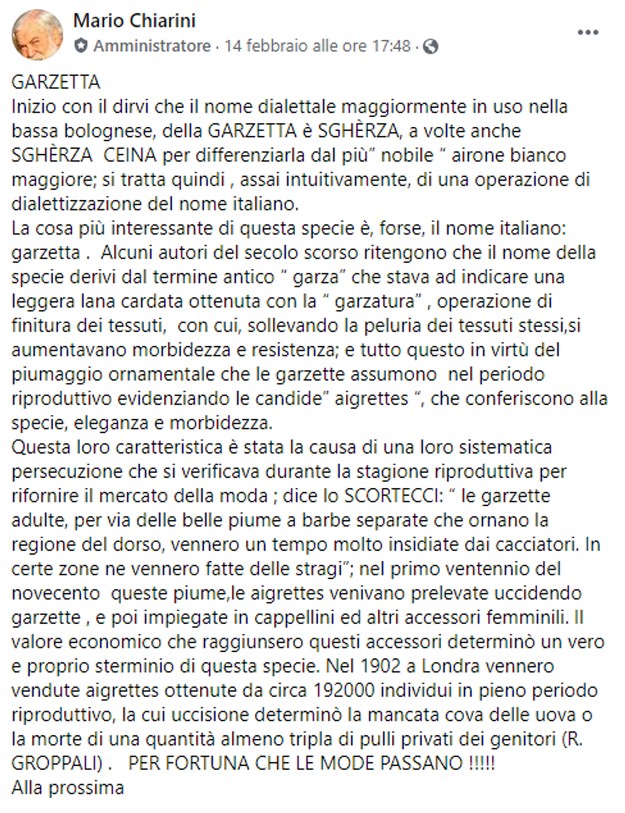



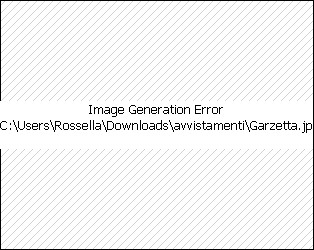
Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NITTICORA


Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RIGOGOLO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BALLERINE
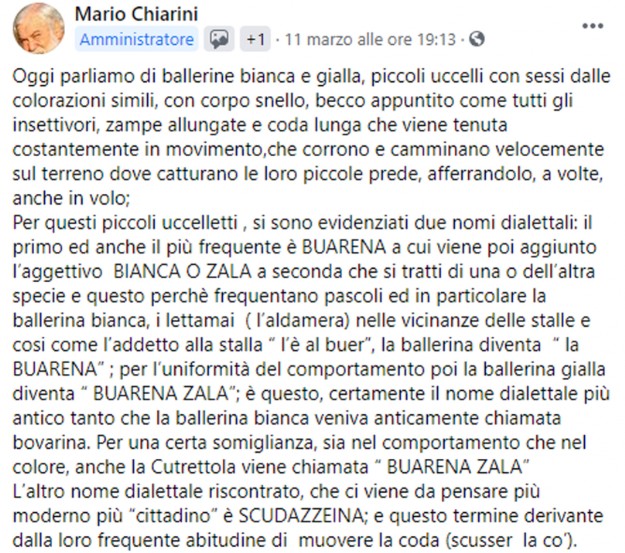





Ascolta il verso
Ballerina gialla
Ascolta il verso
Ballerina bianca
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RONDONE
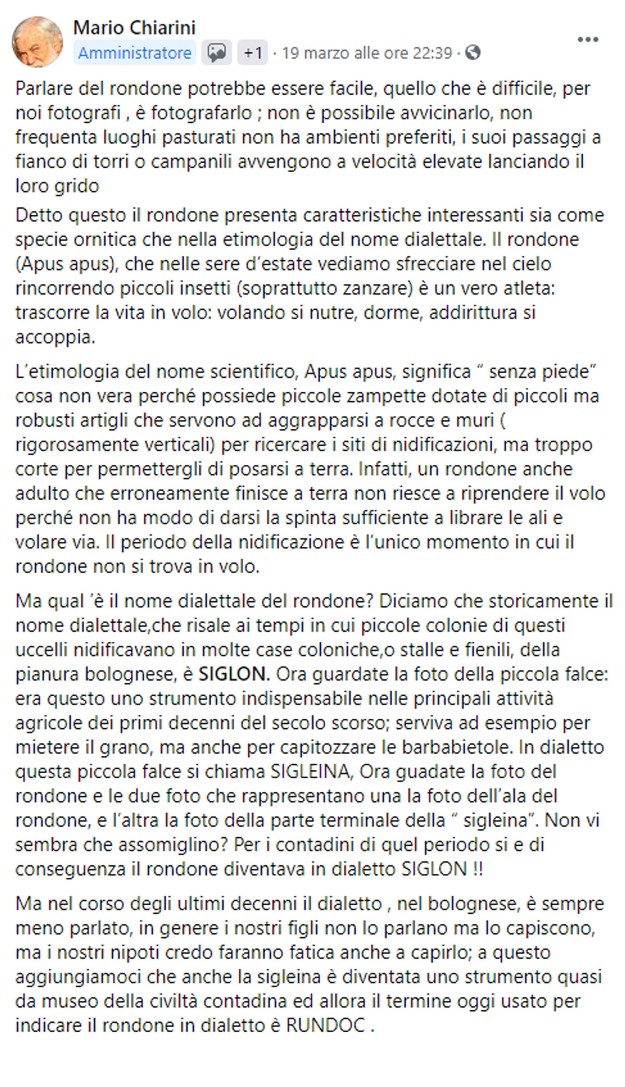





Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SALTIMPALO E STIACCINO
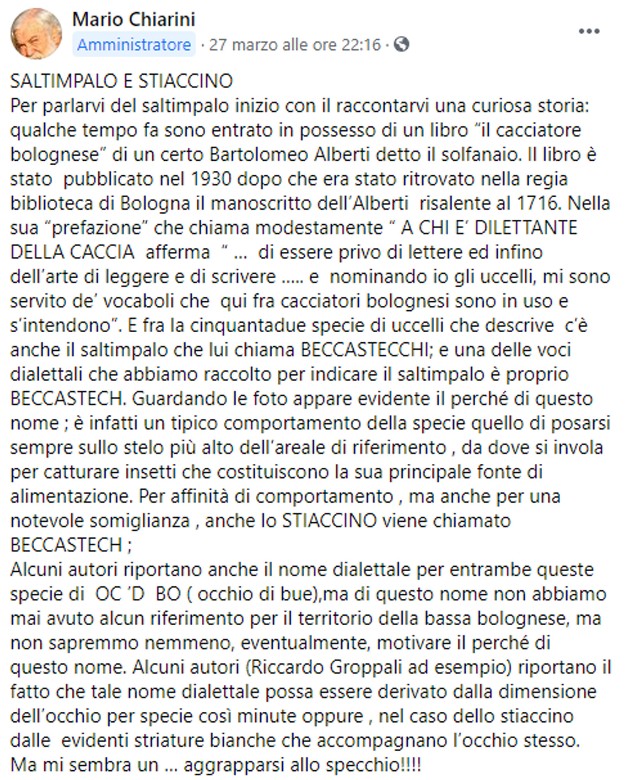



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CANAPIGLIA
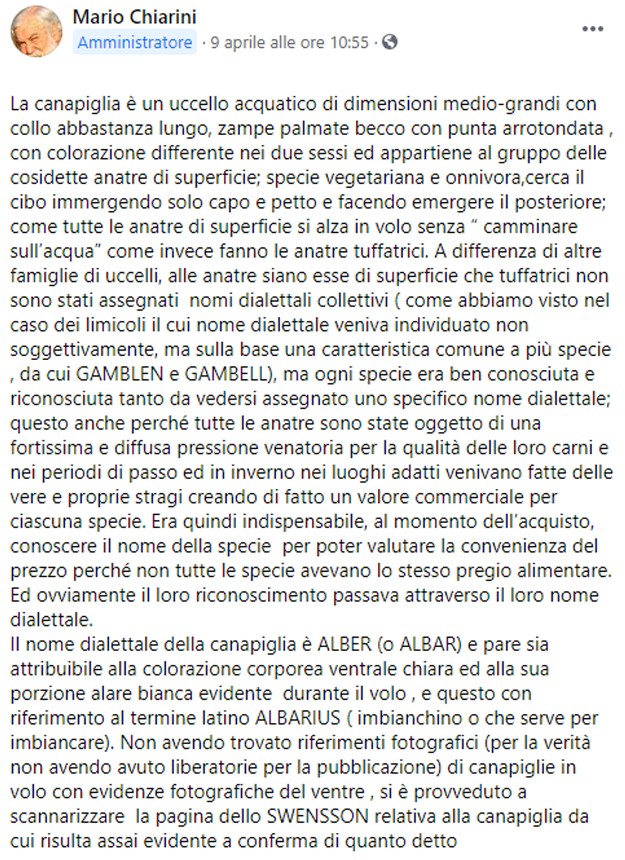



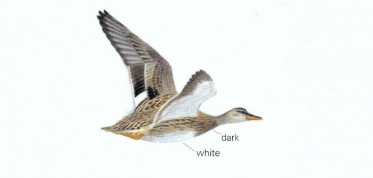
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAVONCELLA
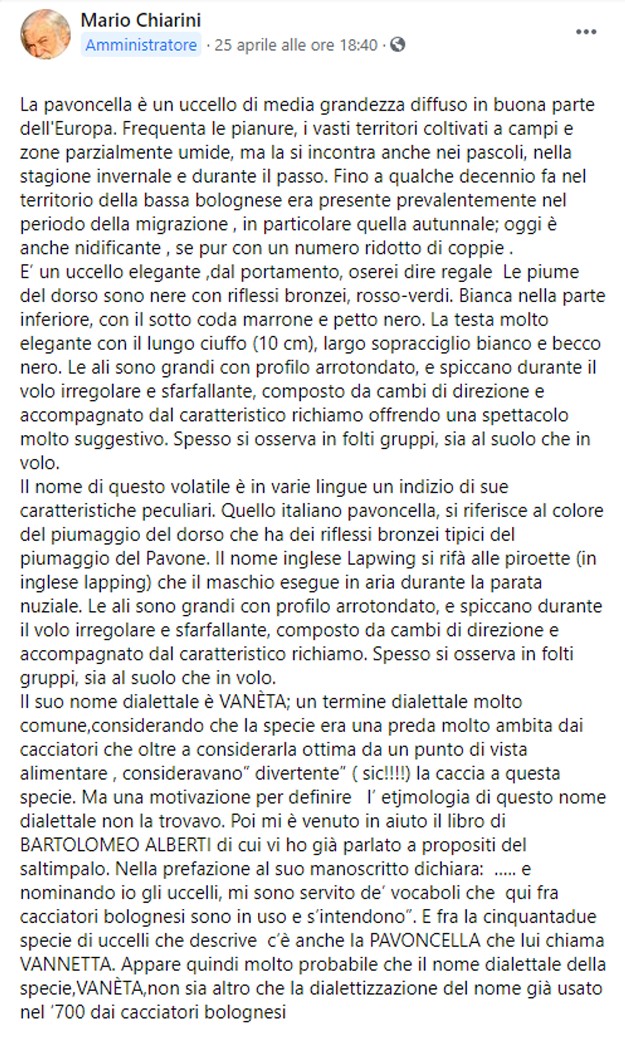




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________