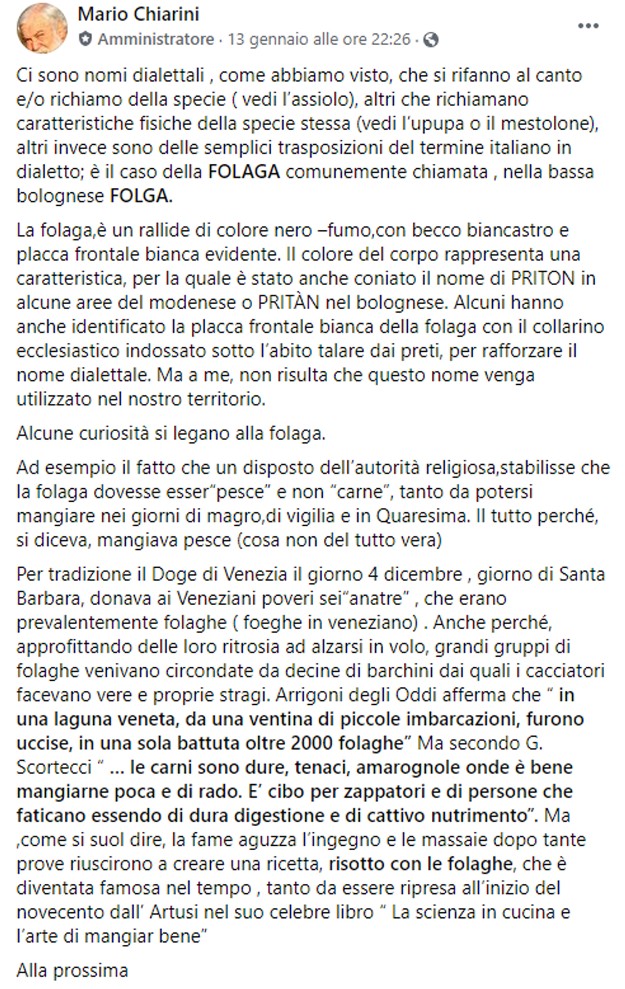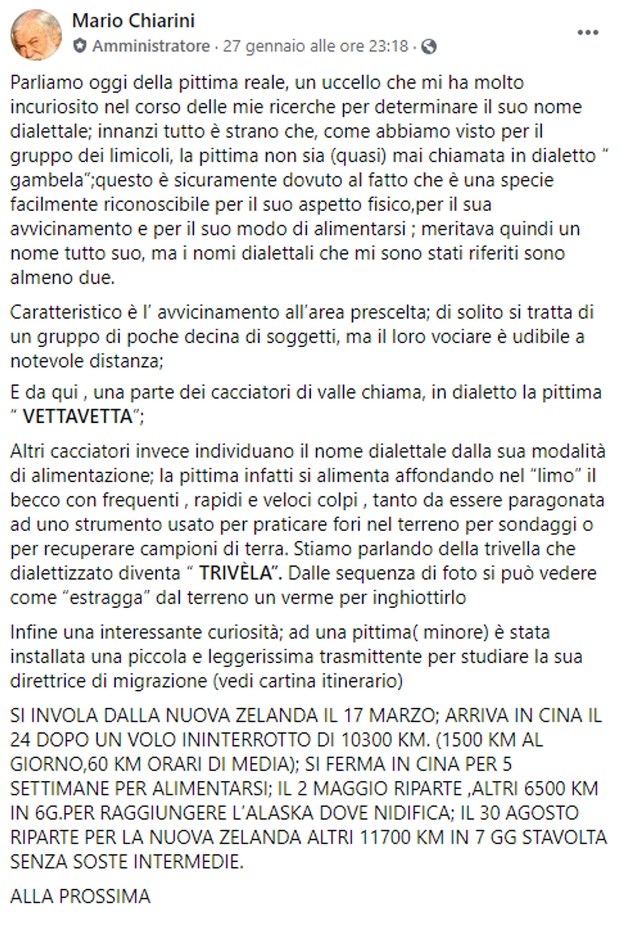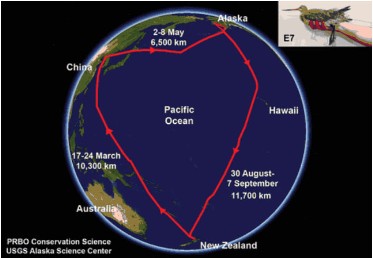Etimologia nomi da facebook pag2 - Bentivoglio e dintorni
Menu principale:
Etimologia dialettale dei nomi degli uccelli della Pianura Bolognese
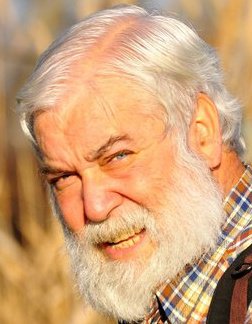
I RACCONTI DI MARIO
SU
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LIMICOLI
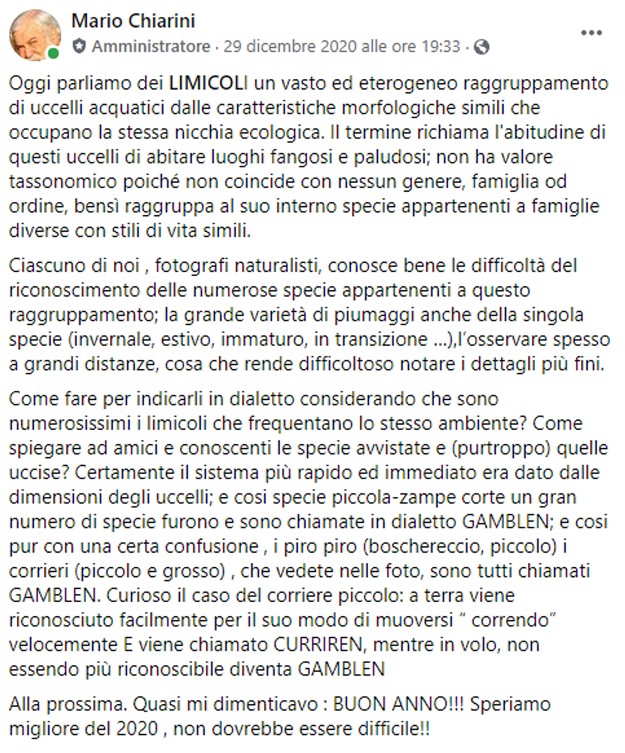




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AVERLA
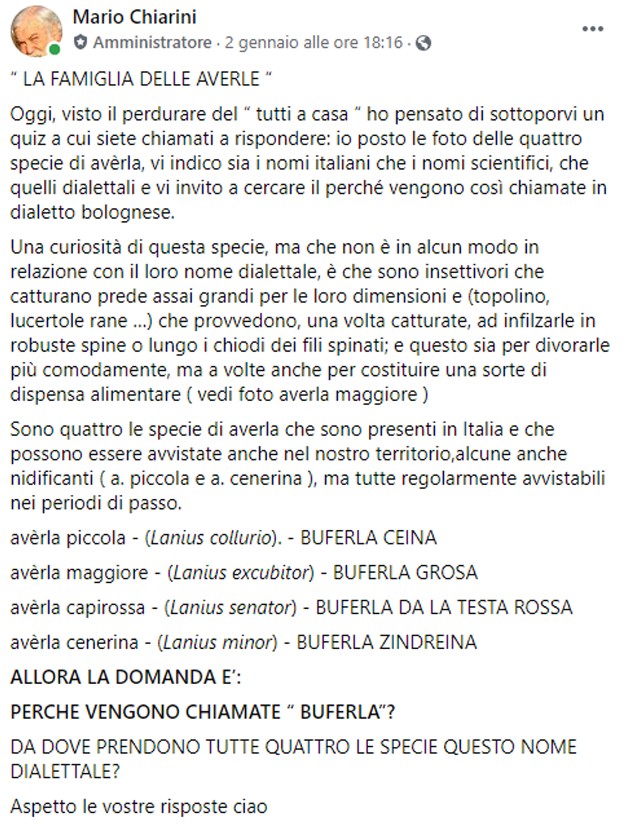


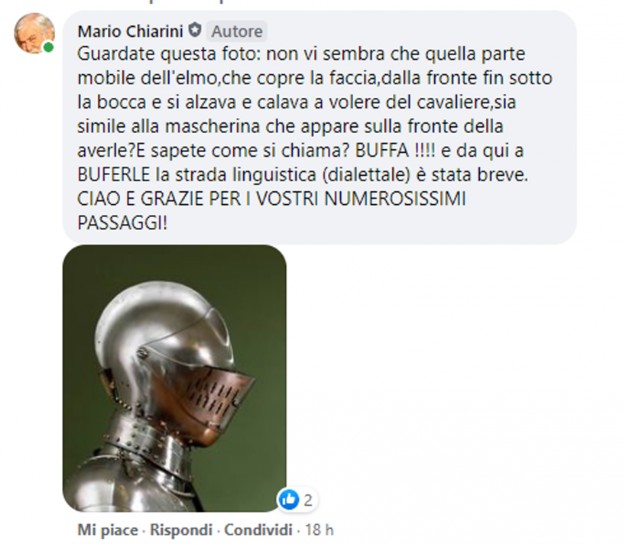

Ascolta il verso
della Averla Maggiore


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MORIGLIONE
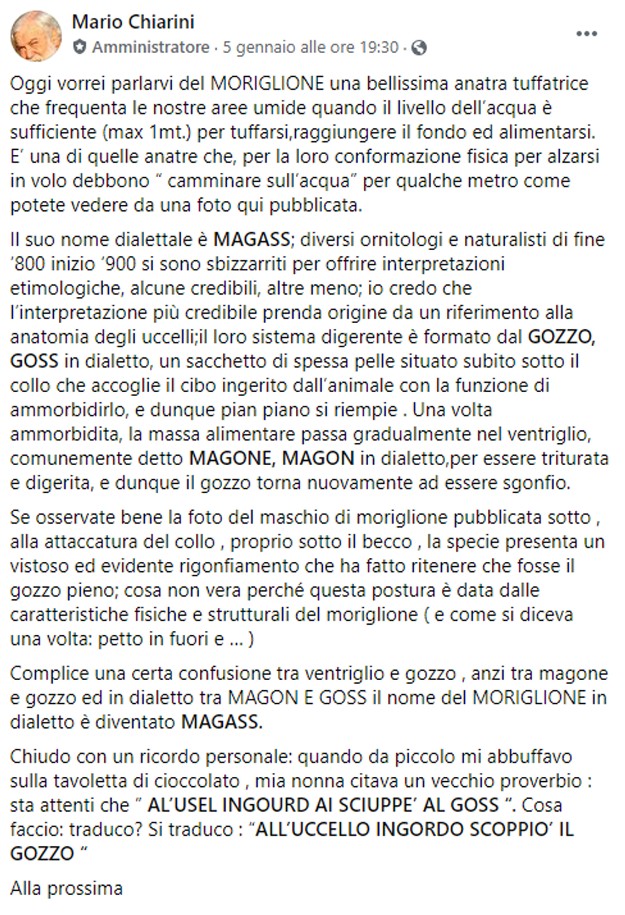





Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, SCHIRIBILLA, VOLTOLINO
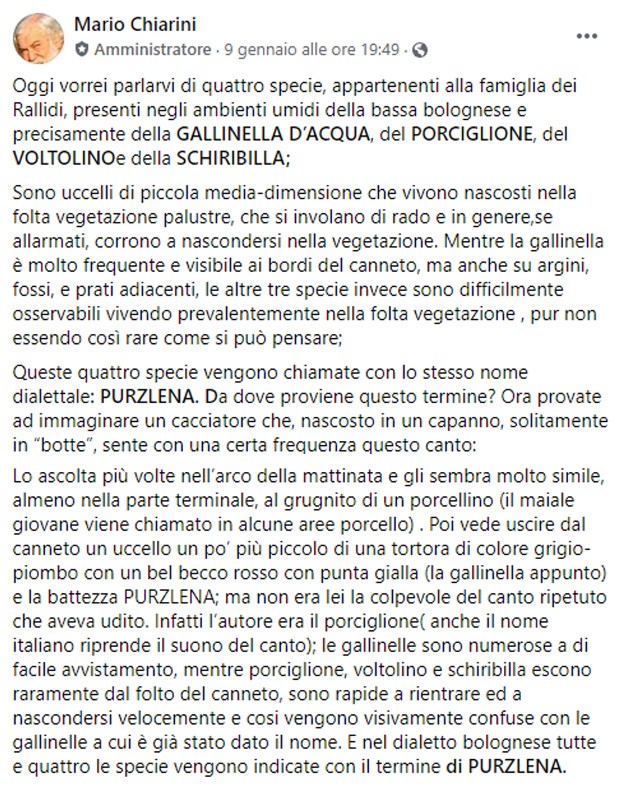





Ascolta il verso
del Porciglione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FOLAGA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ALLODOLA
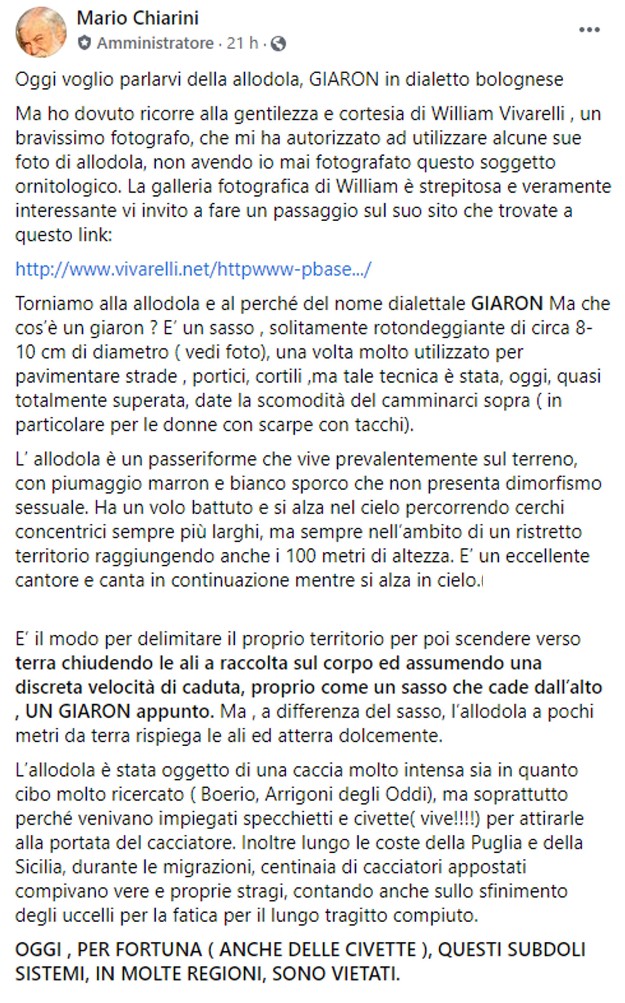





Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LIMICOLI seconda parte
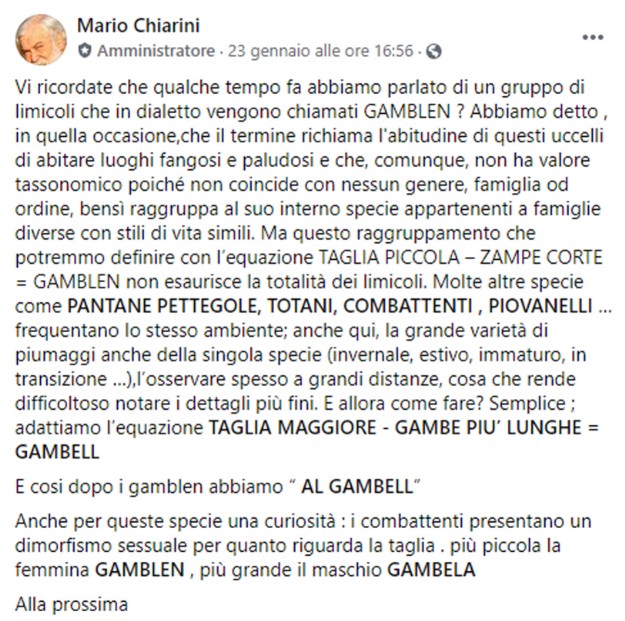





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PITTIMA REALE


Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TARABUSINO
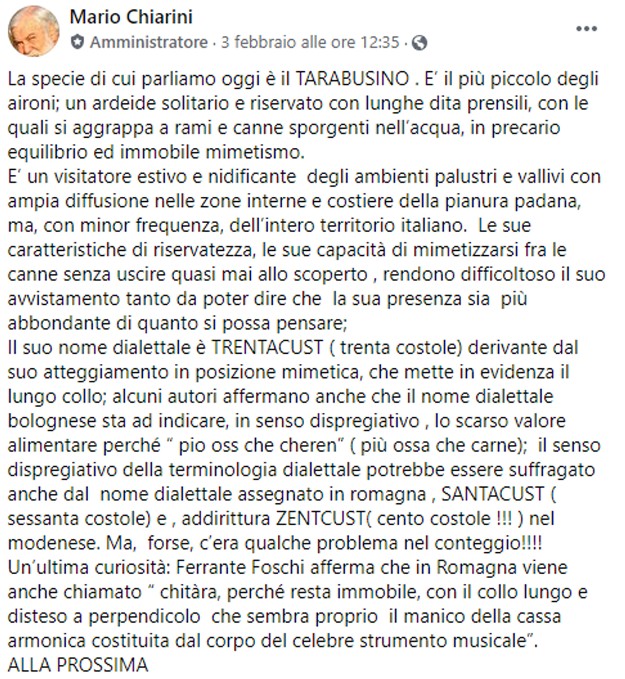





Ascolta il verso
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________